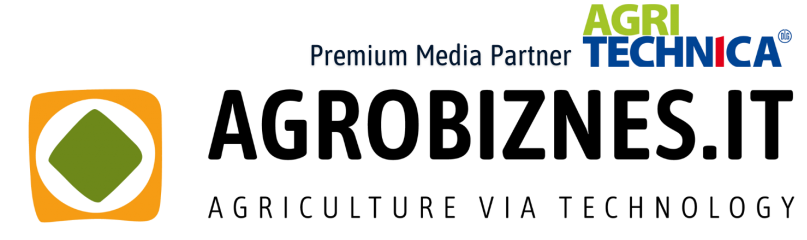Alluvioni devastanti e lunghissime siccità. L’innalzamento delle temperature globali sta minando la produzione agricola, decimando i raccolti, come è successo nei mesi scorsi in Emilia Romagna, la food valley italiana.
Gli effetti della crisi climatica sulle nostre coltivazioni non si limita a questo: crea anche condizioni più favorevoli per la trasmissione di parassiti e malattie che indeboliscono gli alberi da frutto. La PAC (Politica Agricola Comune) può essere un’alleata fondamentale per le sfide di mitigazione e resilienza del settore, a partire dalla strategia per ridurne le emissioni di gas serra.
Agricoltura vittima e colpevole della crisi climatica
Secondo l’Ispra (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale), l’agricoltura è la terza fonte più importante di gas climalteranti dell’economia europea. Contribuisce a circa il 10% delle emissioni del continente, principalmente attraverso l’uso di fertilizzanti (38%), il processo digestivo dei ruminanti e la fermentazione del letame (61%) e i macchinari agricoli alimentati a combustibili fossili, utilizzati nei campi.
Il tema è stato al centro di diversi dibattiti internazionali. Alla Conferenza di Parigi sul Clima del 2015, si è stabilito l’obiettivo di limitare l’inquinamento agricolo, ma senza intaccare la produzione alimentare. Una sfida per la quale i fondi della PAC sono fondamentali.
Le diverse versioni della PAC che si sono succedute negli anni hanno dato via via maggior importanza alle misure volte alla mitigazione e al contrasto alla crisi climatica. Nel 2007 sono diventate una priorità formale, mentre nel 2013 la strategia climatica è stata integrata tra gli obiettivi formali della Politica di sviluppo rurale. Questo impegno sembra però essere rimasto solo sulla carta.
Servono provvedimenti più incisivi
Anche se la PAC 2023 – 2027 promette un’azione più incisiva a favore della tutela del clima, in accordo con il Green Deal, l’applicazione di pratiche agricole meno impattanti è riservata ai singoli beneficiari dei fondi. Attualmente la sola misura obbligatoria per gli Stati membri è la n. 10 agroalimentare, che serve principalmente per sostenere la gestione integrata dei fertilizzanti e la diversificazione delle rotazioni delle colture.
Mancano quindi misure rigorose in materia di emissioni. Secondo le organizzazioni ambientaliste, come emerso dal convegno annuale Metropoli Agricole di Fondazione Cariplo, Bruxelles dovrebbe incentivare maggiormente l’aumento di azioni per il sequestro del carbonio nei campi. La Politica agricola comune già prevede questo tipo di misure, ma non impone agli agricoltori di tenere il conto complessivo di tutte le emissioni di CO2 provenienti dalle diverse fonti.
Stoccare la materia organica di origine vegetale nel suolo, coltivare piante e radici profonde, razionalizzare l’applicazione del letame prodotto dagli animali, del pacciame e del compost potrebbe fare una grande differenza nell’arginare il surriscaldamento globale.
Anche la riduzione dell’uso di prodotti chimici e la promozione della silvicoltura, di prati semi-permanenti (oltre i 5 anni) e l’uso di leguminose, al posto dei fertilizzanti minerali potrebbero essere interventi determinanti. Il settore agroalimentare ha infatti il potere di preservarsi dai cambiamenti climatici, diventando più sostenibile.